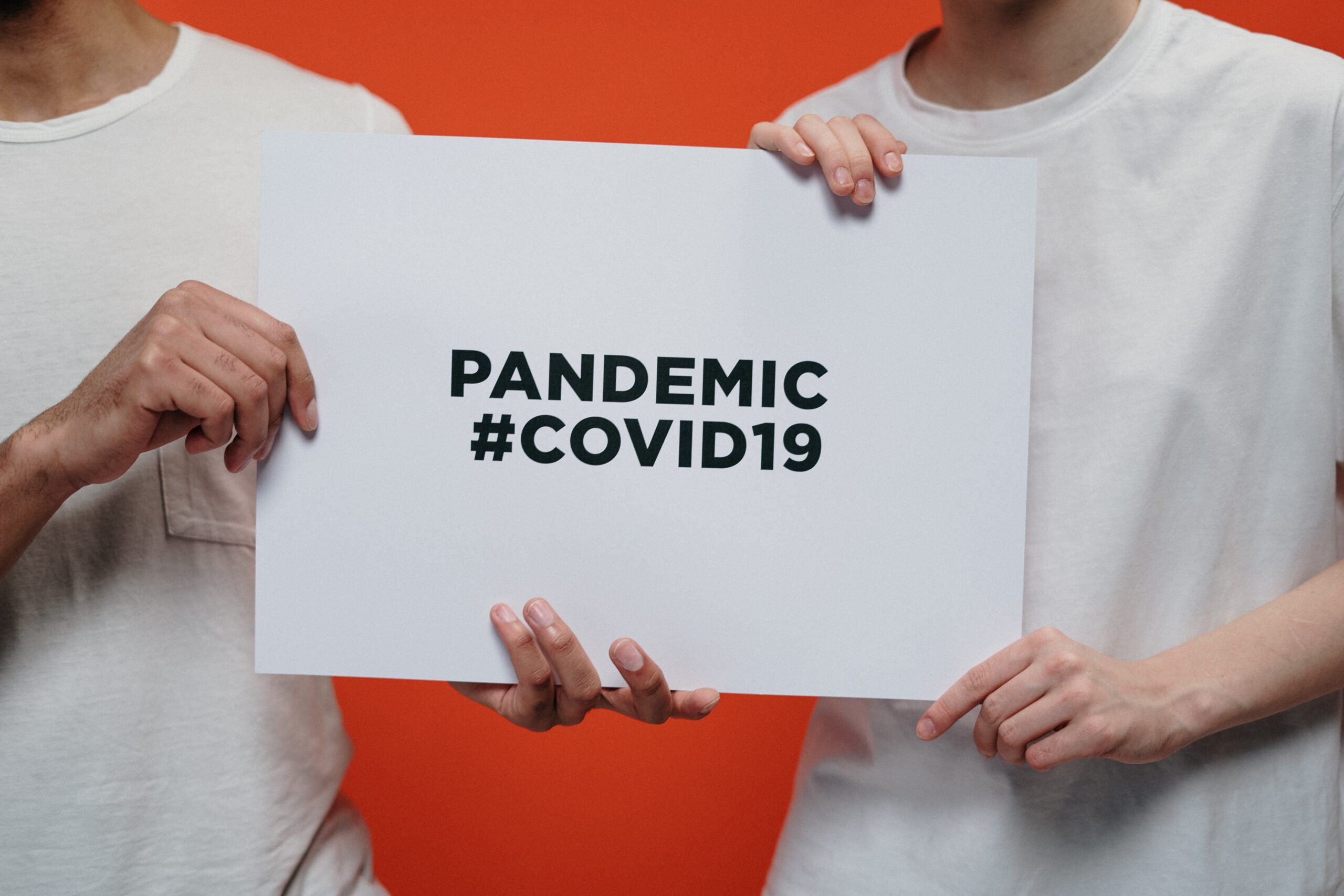photo by cottonbro
Il lavoro che fanno oggi gli studiosi di filogenetica dei virus è quello di mettere a confronto le varie “versioni” di un virus. Confrontano così gli errori di replicazione, riuscendo a risalire all’antenato comune e alla data dello spillover. Ovvero il momento in cui il virus – nel nostro caso il SARS-CoV-2 – è saltato per la prima volta dal suo reservoir naturale (quasi certamente un pipistrello) all’essere umano, per il tramite di un ospite intermedio ancora sconosciuto. ScienzainRete spiega in un articolo molto interessante tutto il processo.
Per poter leggere il codice di un virus occorre effettuare un’operazione detta sequenziamento genomico, con la quale, a partire da un campione biologico, si ottiene una trascrizione del genoma, cioè l’ordine esatto nel quale si dispongono, lungo i due filamenti che formano la “doppia elica” del DNA, le quattro basi azotate (adenina, citosina, guanina e timina) che costituiscono l’alfabeto della vita. Nel caso del nostro virus, il cui genoma è costituito invece da un singolo filamento di RNA, troviamo un’altra base, l’uracile, al posto della timina.
Quando il virus entra nel citoplasma delle cellule umane, utilizzando la proteina spike come una chiave falsa per forzare i recettori ACE2 presenti sulla superfice delle cellule, prende possesso dei meccanismi di produzione delle nuove molecole della cellula, che inizia così a produrre tante copie del RNA del virus anziché il proprio. Ma la natura non è perfetta e così, in questo processo di replicazione all’interno delle cellule umane, il virus può “mutare”, possono cioè verificarsi errori casuali nel processo di trascrizione del genoma virale, e le nuove copie di RNA possono avere modifiche rispetto a quella originaria.
Il ruolo dei filogenetisti non è quindi soltanto quello di guardare indietro e cercare di ricostruire la storia passata del virus, ma anche quello di osservare il percorso evolutivo del patogeno e le sue mutazioni, attuali e potenziali. Dal momento che questo processo avviene continuamente, l’emergere di nuove varianti è un evento prevedibile, non è di per sé motivo di preoccupazione, e il virus SARS-CoV-2 non fa eccezione. Ci sono virus più o meno soggetti a mutare, ma le evidenze che emergono dai primi mesi della pandemia confermano il SARS-CoV-2 come un virus abbastanza stabile.
La maggior parte delle mutazioni – scrivono Curiale, Castilletti, Di Caro ed Ippolito – non ha un impatto significativo sulla diffusione del virus, ma alcune mutazioni o combinazioni di mutazioni possono fornire al virus mutato una sorta di vantaggio evolutivo, come una maggiore trasmissibilità o la capacità di eludere la risposta immunitaria dell’ospite. Se, dunque, una mutazione del genoma, generatasi casualmente, permette al virus di riprodursi con maggiore efficienza e rapidità e/o di adattarsi meglio all’ambiente nel quale si trova, può diventare dominante e soppiantare il ceppo originario o altre varianti meno efficienti dal punto di vista evolutivo.
Per l’articolo completo clicca qui